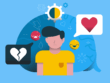Anna chiede un colloquio perché da quando il suo ragazzo l’ha lasciata, tre mesi prima, non riesce a riprendersi.
Quando la incontro per la prima volta mi trovo davanti una ragazza che dimostra più dei 24 anni che dice di avere. Ha un aspetto spento, ingrigito e afferma di essersi vestita solo per venire all’appuntamento perché quando non è al lavoro sta sempre in pigiama.

nizia subito a raccontarmi come sono andate le cose con l’ex ragazzo. Fidanzati da sei anni era stata sempre lei a trainare la coppia: lui le lasciava decidere tutto, dalle serate alle vacanze. Brava nello studio, si era diplomata ed era andata subito a lavorare da un amico del padre. Lui invece era in ritardo con l’Università, lei lo spronava, a volte decideva per lui come organizzare le ore di studio, lo aiutava a ripetere per costringerlo a stare di più sui libri. Nell’ultimo anno lui aveva ricominciato a restare qualche giorno a Roma per seguire delle lezioni, approfittando del letto libero nella camera di un suo amico, anche lui ancora all’Università.
Ed era durante queste “gite”, riferisce in tono sprezzante, che aveva conosciuto “lei”. Glielo aveva confessato piangendo, dicendole che Anna rimaneva la donna più importante della sua vita, ma che pensava anche all’altra.
Anna aveva sentito il mondo caderle addosso: si sentiva ancora più tradita di quanto il tradimento già non lasciasse intendere. Era come se questo non potesse succedere a lei. Descrive una scena molto melodrammatica: lui continuava ad abbracciarla, a ripetere di volerle bene, a muoverla e a stringerla come fosse una marionetta, mentre lei si sentiva senza forze e non riusciva a pensare.
Tornò a casa e si mise a letto per tutto il giorno, telefonandogli però continuamente per chiedere come e perché era successo, cosa provava per l’altra, da quanto durava. Continuò a richiamarlo anche nei giorni seguenti, ripetendogli sempre le stesse cose.
Provarono a rimanere insieme ancora per qualche tempo, ma era impossibile, anche perché lui non le assicurava che avrebbe rinunciato all’altra.
Dopo tre mesi continua ancora a telefonare e a rimproverarlo, a chiamarlo traditore e vigliacco, facendogli pesare tutto il suo malessere. La chiama spesso anche lui, vuol sapere come sta, le dice che è pentito, dispiaciuto. Lei si rende conto che è vero, ma la rabbia non l’abbandona. Ha sempre loro due davanti agli occhi: li immagina che parlano, passeggiano, fanno delle cose insieme. Non può sopportare l’idea che loro stiano bene e lei male. Vorrebbe che lui non chiamasse più, ogni volta le rinnova la sconfitta. Mentre lei vorrebbe trovare a sua volta il modo di ferirlo, di umiliarlo come sente di essere stata umiliata.
Afferma di pensare a lui molto più ora di quando stavano insieme e ciò ci dà modo di introdurre un argomento che tratteremo ampiamente in seguito: nelle situazioni come quella di Anna si soffre non tanto per la mancanza dell’oggetto (ricordando che in psicoanalisi per oggetto si intende sempre un’ altra persona, l’Altro), quanto per l’eccesso di presenza dell’oggetto. “L’ombra dell’oggetto è cadu-ta sul soggetto” dirà Freud con una frase divenuta celebre nel mondo della psicoanalisi.
Anche il resto va male: al lavoro dice di recarsi con sempre maggiore difficoltà, alzarsi la mattina rappresenta una vera lotta e tutto il tempo libero lo trascorre distesa sul letto a fissare il soffitto “struggendosi di pianti”. Amici non ne ha mai avuti molti, ma ora in ogni caso non vede più nessuno.
Vive con i genitori e con un fratello più piccolo. E anche con i familiari, specialmente con la madre, i rapporti sono peggiorati: loro non sopportano più di vederla sempre così, la spronano a reagire, a metterci un po’ di buona volontà, ad uscire; se la prendono con l’ex fidanzato che l’ha “rovinata”, con quell’altra, quella la, rendendole le cose ancora più difficili. Lei, a sua volta, comprende di comportarsi male con loro: sempre nervosa, aggredisce per ogni sciocchezza, ce l’ha con tutti e si lamenta che nessuno la capisce. Non sa perché, ma con loro si sente molto arrabbiata.
La sua vita e lei stessa le sembrano senza alcun valore, non ha più interessi e di niente le importa, crede che nessuno sia in grado di aiutarla. A volte pensa che il suicidio possa rappresentare l’unica soluzione.
Si è rivolta ad uno psichiatra e prende dei farmaci che le fanno sentire meno angoscia, ma non cam-biano il suo stato d’animo.
E’ diventata anche insonne e il non dormire acuisce il suo senso di stanchezza e la difficoltà ad alzarsi al mattino. Inoltre è dimagrita parecchio perché non prova più appetito, non ha proprio voglia di mangiare.
Parla con fluidità, ma con tono basso e monocorde, la mimica e l’espressività risultano impoveriti, solo quando parla di lui e di lei si accende, diventa rossa, alza il tono di voce e si agita tutta. Tutti le dicono che non sorride più e che è diventata acida.
Sa di essere depressa, si è informata su Internet, si è iscritta anche ad un forum ma si sente ancora più confusa. Mi chiede se potrà guarire, se ho già visto persone gravi come lei, se loro sono guarite.
Che Anna soffra di depressione, credo che sia chiaro non solo a lei ma a tutti noi.
Indagini e definizioni
Nel Febbraio 2010 l’Osservatorio Nazionale sulla Salute per la Donna ha pubblicato una indagine da cui risulta che in Italia la depressione colpisce sei donne su dieci, ma soprattutto che tra queste il 50% crede che la depressione sia incurabile e ne ha più paura del tumore al seno. Dall’indagine emerge che le donne sono abbastanza informate su manifestazioni e campanelli di allarme, ma non hanno fiducia nelle cure, non credono che siano efficaci e all’altezza della malattia. Soprattutto non hanno fiducia nei farmaci: ritengono che abbiano effetti limitati nel tempo e che non risolvano le cause principali della depressione.
Ansia e depressione sono ampiamente diffusi nella popolazione e comportano costi elevatissimi per la società. Sulle casse del Paese hanno lo stesso peso del cancro o delle patologie cardiovascolari, pur non ricevendo la stessa attenzione a livello di ricerca e di informazione. Anche le aziende paga-no un prezzo: il 23% delle assenze dal lavoro è causato dalla depressione. Ma ora vi fornirò un dato che sembra incredibile. Sapete quanto è il totale in Europa della spesa per la mancata salute mentale? La cifra enorme di 436 miliardi di euro. Ed è una cifra che risulta dalla Risoluzione approvata dalla Commissione Salute del Parlamento Europeo nel Febbraio 2009. In Europa una persona su quattro soffre di problemi di salute mentale almeno una volta nella vita, mentre molte di più ne subiscono gli effetti indiretti. Il costo finanziario della cattiva salute mentale è stimato tra il 3% e il 4% del PIL degli Stati membri, ossia un totale di 436 miliardi di euro legato in primo luogo all’assenza dal lavoro, all’incapacità di lavorare e al pensionamento anticipato. Approvando la rela-zione il Parlamento definisce la ricerca della salute mentale una “ priorità d’azione fondamentale.”
Il dato si riferisce ad una popolazione di 83 milioni di persone, pari al 27% di tutta la popolazione UE e tra questi la depressione riguarda 19 milioni di persone.
Ma cos’è la depressione?
Il concetto di depressione è antico di almeno 2500 anni ed ha subito nel tempo importanti cambiamenti dettati in larga misura da elementi storici e da influenze culturali. Bisogna però attendere i primi decenni del ‘900 perché si sviluppino strumenti utili in funzione sia diagnostica che terapeutica.
In particolare il punto di vista psichiatrico si è ulteriormente evoluto a partire dai primi anni ’70. Fino ad allora prevaleva l’idea secondo cui lo studio della depressione avesse in definitiva chiarito quasi tutti i dubbi che la riguardavano. Essa veniva infatti sostanzialmente esaminata o dal versante della cosiddetta psicosi maniaco-depressiva, secondo la definizione che ne aveva dato lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin all’inizio del secolo, o dal versante del quadro sintomatologico fornito dalla cosiddetta depressione endogena, caratterizzata da un decorso tipicamente ricorrente con completa restitutio ad integrum nei periodi intercritici, e dalla presenza di alcuni segni tipici come il peggioramento mattutino, l’insonnia, l’inappetenza, l’umore depresso (alcuni dei sintomi di cui si lamentava Anna). Da questi due versanti la depressione poteva essere esaminata in base a dei criteri abbastanza unitari e definiti e sembrava un campo utile solo per la ricerca biologica e psicofarmacologica.
Oggi questo non è più vero, il pensiero psichiatrico e psicopatologico ha subìto un’evoluzione verso la frammentazione del concetto di depressione: rimane un concetto unitario a livello sintomatolo-gico, nella definizione clinica, ma non lo è più a livello di interpretazione delle cause e di proposte terapeutiche. Già l’introduzione da parte del DSM-III-R del concetto di depressione maggiore che ha sostituito quello desueto di depressione endogena o primaria, ha fornito un importante strumento di discriminazione diagnostica. In questo modo è stato introdotto un criterio quantitativo e più dinamico in luogo di una qualitativo: la depressione maggiore si distingue da quella minore per avere uno spettro sintomatologico più ampio. Cioè i sintomi sono di più nella depressione maggiore, ma non sono necessariamente più gravi.
( Il DSM è il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Fu redatto dall’APA nel 1952 nella sua prima versione, poi è stato universalmente adottato. Si è giunti alla versione IV, la versione V è attesa per il 2012).
Inoltre la frequente comorbilità con l’alcolismo, l’abuso di sostanze, il disturbo ossessivo compulsivo, il disturbo da attacchi di panico e di agorafobia, la nevrosi d’ansia e le nevrosi fobiche ha ampliato moltissimo il campo di interesse della depressione, tanto da essere giunta a rappresentare quasi una condizione esistenziale, condizione che si nota anche nel linguaggio comune: oggi si dice “sono depresso” per esprimere qualunque emozione che vada dalla tristezza all’irritabilità. Il “sono depresso” ha sostituito il “sono esaurito” di qualche tempo fa.
Ma, oltre a quelli elencati più sopra, un quadro sintomatologico particolare si è venuto ad impossessare prepotentemente della depressione, quando però la depressione non viene riconosciuta come disturbo psicologico, quando è mascherata: sto parlando del grande capitolo delle malattie psicosomatiche.
Il disturbo psicosomatico e dell’umore
Certamente la depressione è un affetto che con intensità variabile accompagna le malattie somatiche. Molto spesso la perdita della salute è seguita da sentimenti depressivi. Ma quando parliamo di malattia psicosomatica poniamo l’accento proprio sull’aspetto psicologico del disturbo, a significarne la caratteristica di causalità primaria. Molti pazienti infatti, pur avendo disturbi di origine psicologica, quando entrano in contatto con la medicina generale non possiedono altro linguaggio che quello del corpo per esprimere il loro disagio. Il medico non specialista in psicopatologia, preparato ad intervenire sul corpo, individua con difficoltà, o non individua affatto, la patologia psichica che sottende queste situazioni. Il corpo è d’altronde il mezzo più elementare con cui l’individuo si pone in relazione con l’ambiente ed è proprio utilizzando questo veicolo che le emozioni inviano i loro messaggi secondo un codice mascherato: è una specie di “linguaggio del corpo”, una delle modalità che i conflitti intrapsichici utilizzano per esprimere lo stato di allarme e di tensione che viene ad accumularsi e che non si esprime direttamente con sintomi psicopatologici.
Soprattutto in età infantile è evidente una espressività non immediata dei sintomi psichici ed una invece concomitante manifestazione di disturbi somatici ad esprimere, col vomito, il pianto, la stitichezza, l’insonnia etc., i sottostanti stati di tensione psichica.
Le ricerche epidemiologiche sono concordi nel sostenere l’elevata incidenza di disturbi somatici che mascherano una sintomatologia psichica e che vengono osservati negli ambulatori dei medici generici e nei reparti di medicina e chirurgia generale. Si ritiene che più del 50% , ripeto, più del 50% di tali pazienti presentino al medico un sintomo fisico che ne copre uno psichico. Il malato depresso giunge all’osservazione dello psichiatra o dello psicologo con dei lunghi ritardi, a volte di anni, a volte non giunge mai, restando in contatto con il medico generico che lo tratta in modo improprio.
Nel frattempo viene attuata una lunga serie di esami di laboratorio all’inseguimento, di una malattia che non c’è, che muta continuamente di espressività, a malapena etichettata con diagnosi incerte: insufficienza epatica, artrosi, colite, disturbi cardiaci, carenze di minerali vari e così via. Frequentemente avviene che il medico, assillato dal paziente che non guarisce, lo indirizza in ambiente ospedaliero e qui si attua la seconda serie di interventi errati, inutili e costosi: ripetizione di esami di laboratorio superflui, terapie farmacologiche inefficaci e spesso dannose, non di rado anche interventi chirurgici inutili.
Sarebbe molto importante conoscere e diagnosticare questa modalità di espressione della depres-sione attraverso il soma, perché è nel suo precoce riconoscimento e nel suo adeguato trattamento che si trova la possibilità di una soluzione. In primo luogo perché il paziente continua ad essere malato, soffre, è sempre più scoraggiato e tende a deprimersi ancora di più aggravando ulterior-mente un quadro già compromesso, e poi perché il persistere ed il cronicizzarsi di uno stimolo psicogeno non riconosciuto, giunge a far ammalare veramente l’organo o gli organi bersaglio determinando una vera e propria malattia organica. Infine perché, fatto non certo di secondaria importanza considerato la stato di precarietà economica della sanità pubblica, il paziente psico-somatico è estremamente costoso per la comunità: il suo rincorrere incessantemente la presenza di una malattia che giustifichi la sua sofferenza lo induce, certamente con la complicità del medico, a far ricorso a tutti i mezzi diagnostici disponibili pur di ottenere una risposta.
Quando invece la depressione rompe gli argini e si presenta come elemento primario, pur se il quadro sintomatologico può mostrare ugualmente in sovrappiù alcuni o molti dei disturbi elencati sopra, allora essa manifesta un aspetto che è tipico della depressione, che la caratterizza inequivo-cabilmente e che non riscontriamo in nessun’altra sindrome in questa maniera. Esso va ricercato nella tonalità affettiva del depresso, nel blocco dello stato d’animo in una condizione di immobilità, di incapacità a rispondere emotivamente al succedersi degli eventi. E’ caratteristica l’intangibilità dell’umore depresso da parte degli accadimenti esterni. L’esame di realtà è condizionato unica-mente dallo stato d’animo: gli eventi ed episodi della vita reale non influenzano più l’umore, che continua invece nella sua immobilità a modulare con inflessibile monotonia l’esame della realtà.
Infatti la depressione è innanzitutto un disturbo dell’umore, intendendo con il termine disturbo dell’umore le patologie e i sintomi che consistono in alterazioni o anomalie del tono dell’umore, tali da causare alla persona problemi o disagio marcato. Il concetto di tono dell’umore indica il correlato emotivo di fondo della nostra attività mentale. Ogni persona ha un proprio tono dell’umore, che può essere considerato caratteristico del soggetto, e che è il risultato sia della propria dotazione biologica che della propria storia evolutiva.
L’aspetto spento e ingrigito di Anna, il suo sentirsi senza valore, e ancor di più la maniera testarda con cui continua a tormentarsi e a tormentare il suo ex ragazzo testimoniano sia del suo umore depresso che della sua incapacità di tornare ad un esame di realtà adeguato.
La storia familiare
Ed infatti trascorsero molte e molte sedute nel resoconto puntuale e ossessivo di tutti i pensieri relativi a “lui”. Poi a poco a poco Anna cominciò a lasciare qualche spazio per parlare di altro. Iniziò così ad emergere al centro del suo universo affettivo la figura della nonna materna. Vissuta con loro da quando Anna era molto piccola: li aveva raggiunti dal loro paese di origine nel Meridione a seguito della morte del nonno materno, poiché la madre di Anna era figlia unica. Questa nonna era morta circa tre anni prima.
Il padre di Anna aveva conosciuto la madre durante una vacanza con degli amici e la loro amicizia aveva potuto continuare e trasformarsi perché la madre di Anna frequentava l’Università a Roma, risiedendo presso una sorella del padre. Si erano fidanzati e avevano deciso di sposarsi prima che la madre terminasse l’Università perché nel frattempo era rimasta incinta di Anna. Il padre, più grande di qualche anno della moglie, aveva già iniziato a lavorare nel ristorante di famiglia e dopo il parto la madre invece di riprendere gli studi, cominciò a lavorare lì anche lei.
Risale ad allora la presenza, dapprima saltuaria, della nonna che lasciava per brevi periodi il nonno per dare una mano alla figlia nei momenti in cui questa non riusciva a star dietro al lavoro e alla bambina. Poi, quando Anna aveva sei anni, il nonno morì e la nonna si trasferì in pianta stabile da loro. Dopo qualche tempo la madre rimase incinta del fratellino.
Anna trascorreva la maggior parte del tempo con la nonna, era lei che la portava a scuola e la andava a riprendere, che le preparava i pasti e le controllava la cartella, che andava a parlare con le maestre e che conosceva tutte le sue amichette. La madre la vedeva quasi solo al pomeriggio, quando aveva qualche ora libera dal lavoro, ma era molto stanca e le poche energie le dedicava al fratello piccolo. Anche la nonna naturalmente si occupava di lui, ma, dice Anna, il rapporto con lei era diverso, tra loro esisteva qualcosa di speciale.
Alla nonna raccontò i primi turbamenti amorosi, lei la rassicurò quando ebbe le prime mestruazioni e la consolò quando le amiche la facevano soffrire o quando terminò il primo rapporto affettivo.
In un contesto affettivo così dominato dalla figura della nonna lo spazio per gli altri membri della famiglia era per forze di cose limitato, ma il quadro che emergeva era in ogni caso quello di una famiglia abbastanza serena, che col lavoro duro riusciva a darsi un certo benessere economico, che si consentiva e consentiva ai figli molte cose materiali, quasi con il tacito accordo di tutti di compensare in questo modo sia l’impegno lavorativo che le carenze affettive e di presenza che esso imponeva. Anna ricorda sempre con piacere i momenti in cui erano tutti insieme, la settimana di vacanza al mare che si concedevano tutte le estati, la pizza fissa del mercoledì sera, quando il ristorante aveva il giorno di chiusura.
Dopo la maturità Anna si rifiutò ostinatamente di proseguire gli studi. Quella volta neppure la nonna poté spuntarla, decise di andare a lavorare e il padre si rassegnò a raccomandarla ad un suo amico che aveva uno studio di commercialista.
Intanto si era fidanzata. Lui era un po’ più grande e quando Anna frequentava l’ultimo anno delle superiori, era già all’Università. All’inizio fu proprio un grande amore, racconta, lui era dolcissimo e in ogni momento libero stavano insieme. Il primo screzio vero lo ebbero quando si rifiutò di pro-seguire gli studi. Si era diplomata brillantemente e anche lui, come tutti, non riusciva a capacitarsi del suo rifiuto. Anna, del resto, non è che giustificasse molto la sua scelta, diceva che era stanca di studiare, che non voleva continuare e che voleva lavorare. Fu decisa e caparbia e la spuntò.
Morte della nonna e lutto anestetico
Un paio di anni dopo che aveva iniziato a lavorare la nonna si ammalò. Da subito ci si rese conto che non c’erano speranze: un cancro allo stomaco le consentì solo altri sei mesi di vita. Durante tutta la malattia Anna fu sempre estremamente attenta ai bisogni della nonna, le fu molto vicina, ma le sembrava che la cosa non potesse essere così grave.
Quando la nonna morì lei non la lasciò un solo istante fino alla tumulazione, non parlò con nessuno ed era come assente. Ricorda che non sapeva bene cosa provava, non riusciva a realizzare davvero che la nonna fosse morta, si meravigliava però di non essere riuscita a piangere.
Tornò presto al lavoro, ma all’inizio fu dura, passava ore a non far niente, non riusciva a concen-trarsi. La socievolezza che l’aveva sempre caratterizzata era come scomparsa, non parlava quasi più con i colleghi ed è convinta che se il titolare non fosse stato così buon amico del padre forse anche il posto di lavoro sarebbe stato a rischio. Il ragazzo le fu molto vicino ma neppure lui riusciva a mutare il suo stato d’animo, a rasserenarla un po’. Poi a poco a poco le cose cambiarono fino a che per certi aspetti tutto sembrò normalizzarsi, ma lei disse che non si sentiva quella di prima. Era come se un velo spesso fosse calato tra sé le cose e le persone. Tutti i rapporti affettivi, specialmente il rapporto con il fidanzato, erano divenuti meno intensi e gratificanti.
Il quadro che ho descritto in maniera da sembrare il resoconto solo di qualche seduta, si è delineato in realtà in questo modo dopo circa un anno di terapia con incontri due volte la settimana. All’inizio emergeva qualcosa solo quando il rancore e la rabbia verso l’ex ragazzo lasciavano un po’ di spazio: qualche minuto alla fine delle sedute, un accenno su qualche episodio particolarmente significativo. In seguito il racconto, pur se narrato sempre in maniera abbastanza frammentaria, cominciò ad assumere una sua coerenza.
La storia di Anna fino a questo momento mostra almeno due aspetti particolari: uno dato dal legame così esclusivo con la nonna; l’altro relativo al suo modo di affrontarne la morte.
Soffermiamoci per il momento su questo secondo aspetto. Noi sappiamo per esperienza che il lutto è il modo per elaborare la situazione emotiva della perdita di una persona cara in modo che si possa realizzare il concetto generale della separazione tra i vivi e i morti: è un concetto fondamentale allo scopo di vivere, per evitare che la morte prenda il posto della vita e ci conduca all’estinzione. E’ una legge naturale che permea tutti gli esseri viventi.
Il lutto non è né un concetto psicologico né psicopatologico: il lutto è un concetto antropologico che viene declinato in maniera differente nelle varie culture (ad esempio nella nostra è segnalato dal colore nero e dal temporaneo ritiro dalle attività quotidiane) e che riguarda l’elabora-zione e accettazione della perdita dell’oggetto amato.
Gli autori antichi chiamavano “melanconia anestetica” la reazione al lutto caratterizzata da una sorta di estraneità, di anestesia appunto. Il poter piangere, il saper piangere l’oggetto perduto ne comporta l’oggettivazione, e quindi la separazione. E’ il primo passo per arrivare alla liberazione dei legami che con l’oggetto si erano creati, onde evitare la proprietà transitiva della morte, che è uno dei drammi della vita umana. Se il lutto non è elaborato, infatti, l’oggetto diventa persecutorio; come del resto implicitamente è sempre persecutorio il “revenant”, il cadavere che ritorna, lo zombie.
Ciò che mostra Anna quando la nonna muore è proprio questa sorta di anestesia unita al suo non riuscire a realizzare la morte della nonna. Da sottolineare che la sensazione di Anna è sostanzialmente diversa dalla normale reazione al lutto per cui la mancanza della persona cara sembra si faccia sentire sempre più con il passare del tempo, la reazione di Anna è una sorta di negazione della morte della nonna, un tentativo di non sentirne la perdita.
Abraham e Freud
Oggi fa parte del senso comune collegare la depressione al lutto. Ma non è stato sempre così. Il primo a farlo fu Karl Abraham nel 1912. Abraham era un amico e collega di Freud, uno psicoanalista della prima ora. La correlazione fino ad allora non era mai stata fatta e non era così semplice come oggi può sembrare. E’stato Abraham che ha introdotto il lutto come schema della depressione ( o melanconia, come si chiamava allora indifferentemente) e ha individuato, all’interno di essa, l’elemento dell’aggressività.
Il lavoro del lutto, dice Abraham, è un’operazione che attraverso diverse e faticose fasi porta l’individuo all’accettazione di un diverso principio di realtà: la realtà perduta non esiste più e se ne deve fare a meno. Tutto il lavoro del lutto consiste all’inizio nell’introiettare l’oggetto perduto con tutte le sue caratteristiche allo scopo di trattenerlo ancora. Una volta terminato il lavoro del lutto l’oggetto può essere lasciato andare e se ne può elaborare la separazione. Teniamo a mente i concetti di introiezione dell’oggetto perduto e d aggressività, li ritroveremo spesso, rappresentano un punto di svolta, ed è proprio partendo da essi che la psicoanalisi ha dato la sua spiegazione della depressione.
Nel 1915 Sigmund Freud pubblica “Lutto e malinconia”. E’ il punto di arrivo di una riflessione che era iniziata negli anni ottanta dell’Ottocento e che si è protratta per oltre un trentennio. Mentre aveva affrontato in modo relativamente rapido l’isteria, la nevrosi ossessiva, le psicosi schizofreni-che scoprendo i meccanismi specifici dei disturbi in questione, per la depressione non riusciva a trovare gli strumenti psicologici di accesso. E’ vero che era partito male: considerato che nella depressione grave il desiderio sessuale scompare, ricercava un qualche substrato somatico che la giustificasse. Ancora nel 1897 scrive nel Manoscritto sull’Edipo che la melanconia è da ritenersi solo “parzialmente” dovuta a fattori psichici. Poi, come abbiamo visto, nel 1912 vi fu il contributo fondamentale di Abraham che favorì le ulteriori elaborazioni di Freud. “Il lutto è il contrario della malinconia”, asserisce Freud. “In alcuni individui la perdita di una persona amata (o di qualcosa che la equivalga) produce il lutto, in altri la malinconia. Quando una persona cara muore, l’esame di realtà ci dice che quella persona non c’è più ed esige che tutta la libido sia ritirata da essa (la libido è l’insieme delle forze vitali che ci governano). Ma per abbandonare un investimento libidico importante gli uomini hanno bisogno di tempo: tutti i ricordi, le aspettative, le emozioni legate a quell’oggetto vengono evocati e sovrainvestiti e poi il distacco si realizza in relazione a ciascuno di essi. L’inibizione e la mancanza di interesse dell’Io per le cose del mondo durante il lavoro del lutto, si spiegano appunto con il lavoro da cui è assorbito. Una volta portato a termine il lavoro del lutto, l’Io ridiventa libero e la libido recuperata pronta per essere reinvestita. Queste stesse caratteristiche le ritroviamo anche nella melanconia, con la differenza che il melanconico non termina il lavoro del lutto perché esso è interrotto dal manifestarsi di uno straordinario avvilimento del sentimento di sé, un enorme impoverimento dell’Io. Nel lutto il mondo si è impoverito e svuotato, nella melanconia impoverito e svuotato sembra l’Io stesso. Il malato si descrive come indegno, si rimprovera e si vilipende, estende al passato la sua autocritica ed è assolutamente insensibile alla contraddizione. Evidentemente, dice Freud, in qualche modo egli deve avere ragione: forse è arrivato ad un grado di conoscenza di sé che prima non aveva. Anche perché, nonostante la mole di autorimproveri, nel melanconico manca completamente il senso di vergogna. E’ come se una parte dell’Io si contrappone ad un’altra parte: la critica e la disprezza”. Al tempo in cui Freud scrive “Lutto e malinconia” non aveva ancora elaborato il concetto di Super Io, cioè la parte di noi stessi, che rappresenta la coscienza morale e che si pone come istanza critica dell’Io, a volte in maniera anche molto rigida. Quando Freud parla di una parte dell’Io che ne critica un’altra sta facendo riferimento proprio a quello che più tardi chiamerà Super Io. “Dunque”, prosegue Freud, “se si ascoltano con pazienza le lamentazioni del malato ci si rende conto che la maggior parte di esse si attagliano pochissimo alla persona del malato stesso, si adattano invece perfettamente a un’altra persona che egli ama o ha amato: gli autorimproveri sono in realtà rimproveri rivolti ad un oggetto d’amore e da questo poi distolti e riversati sull’Io. Per questo non hanno pudore e non cercano di nascondersi perche tutto ciò che di umiliante dicono di se stessi in realtà si riferisce a qualcun altro; ed infatti sono ben lungi dal dimostrare nei confronti del loro ambiente, quella docilità e sottomissione che sarebbe lecito attendersi da persone così indegne. Al contrario sono persone estremamente moleste, che si comportano sempre come se fossero offese, sono rivendicative e lamentose”.
Chiunque sia abituato a trattare con la depressione sa bene che il lamento del depresso che si autoaccusa, il suo ripetere “non guarisco”, “sto sempre peggio”, “ non va bene” è qualcosa che mette profondamente a disagio perché si avverte che le autoaccuse veicolano aggressività.
E partendo proprio dal processo di identificazione con l’oggetto perduto, processo del quale ho parlato prima a proposito di Abraham, Freud afferma che quando un depresso critica e accusa se stesso, l’attacco non è veramente diretto verso l’Io, ma verso l’oggetto con cui è identificato: una volta che l’oggetto attaccato è deteriorato dall’aggressività, questo “cadavere putrescente” con il quale l’Io è identificato deteriora anche l’Io cosicché la perdita dell’oggetto diviene anche una perdita dell’Io, istallando il circolo vizioso che conduce alla depressione: più il depresso dice “non valgo niente, non miglioro, meglio la morte” etc., più queste accuse vanno a colpire l’oggetto interno che deteriora ancora di più l’Io che è identificato con esso.
“I lamenti sono accuse”, aveva detto in proposito con felice intuizione clinica Freud a completa-mento di quanto detto proprio da Abraham che “le autoaccuse indicano sentimenti ostili rimossi”.
Separazione Io-mondo e rapporto affidabile
Ma finora non abbiamo ancora risposto alla domanda fondamentale: perché alcune persone portano a termine il lavoro del lutto ed altre sprofondano invece nella depressione?
La concezione psicoanalitica del lutto comporta l’idea che ogni lutto sia la riedizione di un’antica perdita, la perdita dell’oggetto primario.
Per tutti esiste nel corso dello sviluppo il vincolarsi della libido ad una persona in particolare, ap-punto l’oggetto primario, che è chi fornisce le cure, il caregiver, come dicono gli Inglesi, in genere la madre.
I rapporti con l’oggetto, nei primi tempi dello sviluppo, sono rapporti essenzialmente narcisistici: non essendoci ancora separazione tra Io e mondo, tra Me e non-Me, il rapporto con l’oggetto esterno è ancora solo rapporto con il proprio Sé, tanto che la scoperta di ciò che sta al di fuori è il primo atto di individuazione in quanto il bambino tende a soggettivare se stesso come qualcosa di separato.
Nelle normali condizioni di sviluppo arrivare a concepire la madre come un oggetto esterno rappre-senta il primo atto di individuazione e comporta la perdita del rapporto con l’oggetto come parte del Sé per riconoscerlo come oggetto staccato, autonomo, ma anche in qualche modo perduto. E’ il pri-mo lutto, paradigma di tutti i lutti che incontreremo nella vita ma anche, come detto all’inizio, l’ine-sorabile via finale dell’evoluzione umana per cui per evolversi bisogna sapersi staccare dall’og-getto amato.
Ma se a causa di una mortificazione reale, di una delusione, di una difficoltà di rapporto con questa figura, la relazione viene disturbata, allora essa non evolve naturalmente verso un processo di individuazione, di separazione e di lutto. Allo scopo di evitare la perdita dell’oggetto amato, per trattenere un oggetto con il quale il legame era diventato labile e insicuro, l’Io rende libera la libido ad esso collegata, ma anziché spostarla su un’altra persona la riporta all’interno di se stesso utilizzandola per instaurare una identificazione con l’oggetto amato. Di fatto si tratta di abbandona-re un oggetto verso il quale il legame è risultato labile per ricreare una situazione narcisistica, una regressione al narcisismo iniziale, l’Io torna ad amare se stesso perché l’oggetto verso cui si era riversato l’amore non si è dimostrato affidabile.
Questo ritiro serve a sottrarre dalla dissoluzione l’amore verso l’oggetto e l’Io identificandosi con esso ama se stesso nell’oggetto. Ma per via dei sentimenti ambivalenti e aggressivi provati verso un oggetto deludente, l’Io odia l’oggetto e odiando l’oggetto l’Io odia anche se stesso. Meno l’oggetto d’amore è disponibile, più i sentimenti aggressivi saranno preponderanti. Inoltre il processo di introiezione di fatto rende impossibile un compiuto processo di individuazione e separazione perché se l’oggetto è introiettato il distacco dall’oggetto diviene impossibile. Tra poco approfondiremo meglio questo punto. Intanto possiamo dire che la crescita non è mai indolore e l’individuazione non arriva di colpo, è il risultato di un lungo processo che costringe sì a perdere il meraviglioso rapporto fusionale con l’altro per lasciare però emergere un essere umano autonomo. Qual è allora il discrimine che consente di arrivare a separarsi dall’oggetto primario senza incorporarlo, rendendo possibile la separazione? Teniamo presente la premessa che in psicologia niente è tagliato di netto, le differenze sono più quantitative che qualitative e il rapporto con l’altro è molto più complesso di quanto può emergere da queste mie parole. I confini tra separazione e incorporazione sono flessibili e permeabili e riguardano più i singoli aspetti che il rapporto totale. Ma per i nostri fini accettiamo di stabilire confini più netti in modo da sperare di ottenere un’esposizione più chiara. Ciò vale ancor di più per quanto dirò tra poco a proposito del rapporto madre-bambino. Anche qui le cose sono più complicate di come apparirà dalla mia esposizione, né quello che accade tra mamma e figlio può essere interpretato come qualcosa da addebitare alla responsabilità di lei. Ma anche in questo caso perdonate la semplificazione.
Dunque il rapporto madre-bambino deve basarsi su un grado di attendibilità sufficientemente buono: la madre non può certamente essere disponibile sempre e per tutto il tempo, ma un giusto grado di attendibilità è necessario.
Un bambino che ha la mamma di fronte la percepisce visivamente, ma quando la madre lo aggira e gli passa dietro egli non ha alcuna garanzia che la madre esista ancora. Per questo con i bambini ha tanto successo il gioco del cucù, cioè dello scomparire e del riapparire, la ricomparsa provoca gioia perché rassicura dall’angoscia dell’assenza, della scomparsa, e nel contempo serve a stabilire per loro la cosiddetta costanza d’oggetto, cioè l’oggetto non smette di esistere anche se non lo vedono.
Ma se la madre troppo spesso non riappare quando è attesa, se non riesce a costruire un universo sufficientemente attendibile per il bambino, allora egli non potrà costruire la sicurezza basata sulla presenza certa della madre e si sentirà abbandonato e in preda degli eventi.
L’arrivo della nonna e le deleghe familiari
Abbiamo visto quanta difficoltà ebbe la madre di Anna nel seguire lavoro e famiglia finché non arrivò la nonna. Anna si attaccò a lei come al primo vero punto di riferimento stabile della sua vita, ma aveva sicuramente incontrato tante difficoltà fino a quel momento proprio per creare la costanza d’oggetto. L’insicurezza di fondo causata dall’instabilità del rapporto con la madre si riverberò inevitabilmente nel rapporto sostitutivo con la nonna: Anna ha potuto godere di momenti di grande stabilità con lei, ma sul fondo persisteva la paura che prima o poi anche questo rapporto potesse diventare instabile, che anche la nonna, come la madre, potesse non ritornare dalla stanza accanto. Era come se Anna si stesse preparando ad esorcizzare un abbandono che avrebbe potuto rieditare i vissuti dolorosi e traumatici della primissima infanzia. Vissuti che comprendevano certamente una grande dose di aggressività e di rabbia che solo l’estremo bisogno e la dipendenza riuscivano a far rimanere sullo sfondo, integrati ed equilibrati dall’affetto e dalla tenerezza che si provano in ogni caso nei confronti di chi si prende cura di noi e ci fornisce benessere e un certo grado di sicurezza.
La presenza costante della nonna aveva consentito ad Anna di vivere attraverso di lei le fasi di passaggio che avrebbe dovuto vivere con la madre. E’ certamente esperienza di tutti, specialmente nella società attuale dove a lavorare sono spessissimo entrambi i genitori, che siano i nonni a farsi carico della crescita dei nipoti. Ma le figure di riferimento affettivo e normativo continuano a rima-nere i genitori. Nel caso di Anna si era verificata invece una specie di delega in bianco alla nonna.
I motivi possono essere molteplici. La nonna doveva aver ricercato una specie di esclusività nel rapporto con la nipote per compensare il senso di dolore e di solitudine derivante sia dalla morte del marito che dall’aver abbandonato i suoi luoghi di origine. Inoltre l’essere “la madre” di Anna le consentiva di risperimentare un ruolo che le forniva sicurezza ed anche in fondo il senso di una nuova giovinezza.
Molte volte vediamo una specie di lotta tra madre e figlia, o tra nuora e suocera, su cosa vada meglio per i propri, rispettivamente, figli e nipoti. Immancabilmente quello che è buono per l’una è pessimo per l’altra e viceversa. Questi scontri, guardati spesso con sufficienza o fastidio da parte degli estranei o dei figli-mariti, in realtà sono fonte di grande sofferenza per le protagoniste, rappresentando spesso la riedizione di uno scontro generazionale non risolto nell’adolescenza: la madre-suocera si proclama forte di una indiscussa esperienza, ma spesso sullo sfondo c’è la volontà di non abdicare per sempre al ruolo materno, alla fecondità (senza contare che spesso si spera inconsape-volmente di rimediare con i nipoti agli errori che si teme si siano commessi con i figli); la figlia-nuora sente di nuovo sopra di sé l’imperio autoritario e genitoriale di chi ti dice cosa fare e non fare, cosa è giusto e cosa non lo è, come se non si fosse mai cresciuti. Lo scontro sembra sulle cose, su quale sia la pappa migliore, l’ora giusta per andare a letto o il vestitino più adatto, in realtà si tratta di una vera lotta per l’attribuzione dei ruoli: di chi vuole acquisirli definitivamente e di chi non vuole definitivamente rinunciarci.
Nel caso della mamma e della nonna di Anna ciò non accadde: la madre sembrò rinunciare senza conflitti o difficoltà ad un ruolo che la nonna prontamente assunse. Anna, dal canto suo, sembrò rispondere molto positivamente al cambiamento.
All’inizio la nonna si era in verità un po’ preoccupata perché aveva notato che quando si allontanava per qualche motivo, e doveva lasciare sola Anna per brevi periodi, al momento dell’allontanamento Anna piangeva e si disperava per avere un comportamento completamente opposto quando rientrava: la ignorava palesemente facendola sentire un’estranea e mettendola a disagio. Se provava lei a riavvicinarsi non c’era niente da fare, Anna continuava ostinatamente a dedicare tutta la sua attenzione a quello che stava facendo ignorandola. La nonna si rassicurò quando parlandone con la madre questa le disse che anche con lei si era sempre comportata così. Per fortuna dopo qualche tempo questi comportamenti si attenuarono, ma non scomparvero.
Madre e padre
E la madre? Perché la madre di Anna aveva così prontamente rinunciato al suo ruolo?
Certo gli affanni derivanti dallo scarso tempo a disposizione, la sensazione di dare troppo poco alla figlia e il senso di colpa derivante, avevano il loro peso. Ma forse pesava di più un confronto mai risolto con la madre nel passato: un’individuazione della propria femminilità, del proprio poter essere madre completa a sua volta, insomma una soggettivazione mai completamente raggiunta. Ho ipotizzato questo perché più volte Anna mi ha raccontato che sua madre si rapportava con la propria, per quanto riguardava Anna, non come una genitrice a sua volta, ma come se fosse solo la sorella maggiore di Anna.
Da non sottovalutare inoltre la situazione che ho appena descritto e che doveva essere molto difficile e penosa da affrontare: il pianto di Anna tutte le volte che doveva lasciarla e la durezza aggressiva e rifiutante di quando si rincontravano. Questo la straziava certamente.
Insomma meglio lasciar fare le cose a chi sapeva farle: in fondo lei è una che si sacrifica, che rinuncia. Non aveva forse così facilmente rinunciato all’Università quando c’era stato bisogno?
Anche il padre probabilmente aveva le sue responsabilità nell’abdicazione della moglie al suo ruolo di madre. Se lei infatti era poco presente lui lo era ancor meno, e probabilmente si sentiva in colpa sia verso la figlia che verso la moglie: con questa per i sacrifici che sapeva di averle imposto con il lavoro, con Anna perché sentiva di portarle via la madre oltre che se stesso. L’arrivo della suocera insomma rappresentò una mano santa anche per lui.
Come tutti Anna aveva bisogno di una figura di riferimento durevole che supplisse alle assenze della madre. Per la loro precarietà non potevano certo essere adatte le varie baby sitter che si erano succedute. La nonna invece era lì ogni giorno e nel giro di poco tempo si ritrovò a svolgere in tutto e per tutto le funzioni di una madre. Anna d’altra parte aveva trasferito su di lei, armi e bagagli, le modalità di legame che aveva con la madre. Ed era molto consapevole di questo: in terapia disse molte volte che da un certo punto in poi si era sorpresa del suo rapportarsi alla nonna quasi come fosse lei la madre. E come abbiamo visto aveva trasferito su di lei anche quel particolare modo di reagire alle assenze. Oggi sappiamo che quel modo di reagire è tipico di un particolare legame che si viene a creare con la figura di riferimento principale. E’ il modo di reagire che gli psicologi chiamano legame da attaccamento insicuro, che si determina originariamente appunto nel rapporto con l’oggetto primario, ma che tende a riverberarsi in tutte le relazioni future, come dimostra l’esperienza.
Bowlby
John Bowlby è lo psicologo inglese che a metà del secolo scorso studiò le modalità di attaccamento dei bambini alle loro madri e introdusse in psicologia i concetti di attaccamento sicuro ed attaccamento insicuro.
A Bowlby l’idea dell’attaccamento venne dopo aver letto i lavori di Konrad Lorenz sull’imprinting, cioè su quel fenomeno per cui i paperi uscendo dall’uovo identificano come la madre , e seguono disciplinatamente, la prima figura a disposizione, fosse anche un uomo.
In particolare coniò il termine “base sicura”, come capacità soggettiva di riconoscere che esiste una persona fidata a cui far riferimento in ogni momento. Questo crea la fiducia in sé e consente l’esplorazione dell’ambiente circostante. Nel momento in cui il bambino avverte qualche pericolo, cessa l’esplorazione e torna dalla madre per rassicurarsi. In questo caso si è stabilito uno Stile Sicuro di Attaccamento promosso da una figura presente, disponibile e attenta ai segnali del bambino, pronta a proteggerlo non appena richiestole. I tratti che maggiormente caratterizzano questo stile sono: sicurezza nell’esplorazione del mondo, convinzione di essere amabile, capacità di sopportare distacchi prolungati, nessun timore di abbandono, fiducia nelle proprie capacità e in quelle degli altri.
Quando invece, scrive ancora Bowlby, la figura di attaccamento risulta poco attenta o disponibile solo in alcune occasioni, impone al bambino frequenti separazioni o anche minacce di abbandono, allora lo stile di attaccamento che si instaurerà sarà del tipo Insicuro Ansioso Ambivalente e sarà caratterizzato dalla mancanza di certezza sull’affidabilità della figura di attaccamento. In questo stile troviamo: insicurezza nell’esplorazione del mondo, convinzione di non essere amabile, incapacità di sopportare distacchi con manifestazioni di angoscia da separazione, sfiducia nelle proprie capacità e soprattutto conseguentemente, rapporto ambivalente verso gli altri. Il tipo insicuro ansioso ambivalente richiede continuamente attenzione nelle relazioni ma la sua insaziabilità tende a far allontanare gli altri. Le sue relazioni sentimentali sono costellate di passione, rabbia, gelosia e ossessività ma pur tendendo ad iniziare i conflitti non arriva alla rottura del legame.
In questo stile di attaccamento tutti avrete rivisto alcune delle modalità di relazione di Anna, compreso quel suo particolare modo di rifiutare il riavvicinamento dopo una separazione. Proviamo a mettere insieme ciò che ha detto Bowlby con quanto esposto prima.
Il bambino che non riesce a stabilire un attaccamento sicuro, una base sicura si trova in uno stato di grande difficoltà. Da una parte l’oggetto è indispensabile, da lui dipendono benessere e soddisfazione, dall’altro è fonte di rabbia e frustrazione per la sua indisponibilità. Ma l’aggressività non può giungere a distruggere l’oggetto di cui si ha tanto bisogno, nel contempo la sua indisponibi-lità è intollerabile. Scatta allora il meccanismo che sembra sanare il conflitto. Allo scopo sia di non distruggerlo che di trattenerlo, l’oggetto viene introiettato: ora esso non può più sfuggire né essere distrutto, ma verso di esso vengono diretti tutti i sentimenti negativi che l’oggetto aveva scatenato nella realtà.
Controinvestimento, oggettivizzazione dell’Io e defusione degli istinti
Poiché però, come abbiamo visto, il processo di introiezione è inestricabilmente connesso con il processo di identificazione, i sentimenti aggressivi che si provano verso l’oggetto ricadono sul Sé. A ciò si riferiva Freud con la frase citata all’inizio”l’ombra dell’oggetto è caduta sul sé”. Inoltre, dal momento che i sentimenti aggressivi, pur se non agiti nella realtà, sono in ogni caso molto pericolosi, devono essere controllati anche se diretti verso l’oggetto interno, cioè verso il Sé. Ciò si verifica tramite il fenomeno del controinvestimento: l’oggetto interno viene cioè investito oltre che di aggressività anche di amore, proprio al fine di riuscire a compensare le cariche aggressive. E’ evidente che più potenti sono le cariche aggressive, più massicci devono risultare i controinvestimenti. Tutto questo lavorio non è senza scotto. Tenere a bada le componenti aggressive comporta un grande sforzo e produce uno stato di forte precarietà.
Questo è quanto schematicamente accade nei casi di attaccamento insicuro con il corollario, tanto per complicare ancora il quadro, che la difficoltà di separarsi dall’oggetto primario si imporrà come modello per le relazioni future, come appunto è successo ad Anna con la nonna ed il fidanzato.
Cioè quando nel corso della vita si tratterà di affrontare una perdita, si riproporrà il problema ormai antico di separarsi da un oggetto amato. Ma se la modalità istauratasi era proprio quella della introiezione invece dell’elaborazione del lutto, l’unica via che resta aperta è una nuova introiezione dell’oggetto allo scopo di trattenerlo, dando inizio a quel processo che trasformando la perdita dell’oggetto nella perdita dell’Io omologato all’oggetto, provoca il senso di impoverimento che apre le porte alla depressione.
Anche i suicidi o i tentativi di suicidio che a volte si verificano durante gli episodi depressivi vanno letti in quest’ottica: l’Io può uccidersi solo quando riesce a trattare se stesso come un oggetto, quando può dirigere contro di sé l’ostilità che originariamente riguardava un oggetto. “Nelle due situazioni opposte dell’innamoramento più intenso e del suicidio l’Io è sopraffatto dall’oggetto, seppure in guise completamente differenti” scrive Freud, ed in effetti in entrambe le situazioni l’esame di realtà sembra passare assolutamente in secondo piano rispetto alla visione dell’oggetto dettata dai sentimenti.
Anche l’insonnia possiamo interpretarla come l’incapacità di ritirare gli investimenti dal mondo, ritiro che ci consente di dormire. Rigidità ed adesività degli investimenti impediscono sia di modificarli che di dislocarli su altre persone.
Ma non è finita.
Ricordate quanto avevo detto prima a proposito dei contro investimenti, cioè delle cariche affettive che vengono dirette verso l’oggetto interno allo scopo di mitigare l’aggressività e riuscire a riportare le cose in equilibrio? Bene, ora, al contrario di quello che accadde nell’infanzia, si hanno purtroppo gli effetti di una legge della quale non ho ancora parlato e che è stata scoperta grazie ad un’altra profonda intuizione di Abraham: la legge della defusione degli istinti, un’altra legge fondamentale del procedere umano. Questa legge dice che tutte le volte in cui esiste una regressione della libido, in cui cioè la libido procede da momenti più evoluti della vita adulta ai momenti più antichi della vita infantile, essa si defonde. Le componenti che sono assieme affettive ed aggressive e che sono sempre legate insieme per dare una costituzione generale armonica nella vita adulta, in questi casi si dissociano: l’aggressività se ne va da una parte e l’amore dall’altra e le due componenti non si mescolano e non si intendono più. Nella depressione, di cui la regressione narcisistica è un fenomeno fondamentale, l’aggressività esce in primo piano, si evidenzia e più era stata forte durante le prime fasi di separazione e aveva richiesto massicce dosi di contro investimento affettivo per essere tenuta a bada, più ora diventa padrona del campo.
E così siamo arrivati alla quadratura del cerchio: in sintesi ciò che conduce alla depressione sono la riedizione dei fenomeni di introiezione e la liberazione delle cariche aggressive defuse.
Torniamo allora ad Anna.
Reazione alla morte della nonna
Abbiamo visto che al momento della morte della nonna Anna si è comportata come se la cosa la riguardasse poco. Possiamo immaginare che proprio in virtù di quanto abbiamo appena detto a proposito della defusione degli affetti, ella abbia dovuto esercitare una cesura, un taglio con la realtà perché consentirsi di accettare che la nonna era morta avrebbe significato risperimentare i forti sentimenti di aggressività che ormai liberati dal vincolo rappresentato dall’affetto sarebbero divenuti padroni del campo. Così Anna fece finta di nulla e passati alcuni mesi le cose sembrarono tornate come prima. Ma non erano come prima, Anna non si era consentito il lutto e ciò, ricordando quanto detto da Freud che il lutto è il contrario della depressione, conducesse verso la depressione, anche se in questo caso una depressione negata, non riconosciuta: una di quelle depressioni in cui il disagio si manifesta principalmente come disagio del corpo, ma che per non sfociare nella depressione conclamata ha di nuovo bisogno di grandi dosi di contro investimenti per tenere a bada l’aggressività. E i contro investimenti durano fatica.
In questo senso possiamo interpretare il non sentirsi la stessa di prima di Anna dopo la morte della nonna: l’energia libidica che prima era disponibile ora doveva essere massicciamente utilizzata per mantenere quella specie di coperchio che aveva messo sulla pentola della sua vita.
Pian piano cominciamo infatti a renderci conto di quanto le cose cambiarono realmente: ricorda che era diventata lamentosa ed irascibile, sempre pronta a recriminare qualcosa al fidanzato, a rimpro-verarlo. Si lagnava molto anche con i suoi e specie con la madre si sentiva molto aggressiva. Soprattutto cominciò a manifestare una serie di disturbi fisici che erano molto fastidiosi, ma erano mutevoli e agli esami strumentali non rivelavano mai niente di concreto.
Insomma, in base a quanto detto finora, possiamo capire che ben prima che la storia tra lei e il suo ragazzo finisca, Anna è già depressa e ne manifesta molti dei sintomi tipici.
Durante il corso della terapia diviene consapevole che il cambiamento del suo umore e la continua preoccupazione di stare male avevano un collegamento con la morte della nonna e che quanto successo dopo la rottura con il suo ragazzo non era indipendente da quanto successo nella sua vita fino ad allora.
Quando scoppia la crisi con il ragazzo Anna si ritrova infatti nuovamente ad affrontare una perdita, e per la sua incapacità di elaborare il lutto anche questa perdita si trasforma in depressione. Questa volta non ce la fa però a mantenere la parvenza di normalità e sviluppa la sindrome depressiva che abbiamo visto all’inizio.
Finale
Per inciso vorrei far presente la dannosità della depressione negata rispetto ad una depressione conclamata. Gli sforzi di Anna erano andati in direzione di mascherare la sua depressione: questo non le aveva impedito di soffrire, ma le aveva certamente impedito di curarsi. E’ lo stesso che accade a tante persone che lottano tutta una vita con malattie inesistenti. E’ un ben triste destino. Certo la depressione spaventa, ma quando individuata si può curare. Una malattia che non c’è, no.
Finora ho parlato solo di depressione conseguente alla perdita di una persona cara. In realtà la depressione può esitare anche a seguito della perdita del lavoro, di un obiettivo non raggiunto, di un fallimento. Il meccanismo è lo stesso illustrato finora perché le cose importanti della vita gli esseri umani le introiettano e le considerano degli oggetti-sé non diversamente dalle persone care.
Da qualche tempo Anna sta frequentando un nuovo ragazzo. I giorni “no” sono ancora molto frequenti, e le varie occasioni di separazione le scatenano sempre tanta angoscia e rabbia. Ma le preoccupazioni psicosomatiche si sono attenuate e nei momenti buoni riesce anche a scherzarci su.
A proposito, si è anche iscritta all’Università, abbiamo capito che il suo rifiuto derivava da un senso di colpa nei confronti della madre: il difficile rapporto con lei le faceva sentire una sua responsa-bilità il fatto che la madre si fosse dovuta sposare, avesse dovuto iniziare a lavorare e rinunciare allo studio perché era incinta di lei, quindi lei non voleva umiliarla ulteriormente superandola anche negli studi.
Dopo quattro anni di terapia abbiamo ancora del lavoro davanti perché le ferite inferte all’uomo impiegano tempo a rimarginarsi ma è indispensabile che ciò avvenga perché esse ci limitano grandemente il dispiegarsi della vita e, come disse negli ultimi momenti della sua vita Heinz Kohut, il grande psicoanalista austriaco emigrato nel Stati Uniti durante il nazismo, “non realizzare gli scopi impliciti nel proprio Sé nucleare è tragico ed è la base della depressione diffusa nella nostra cultura”.